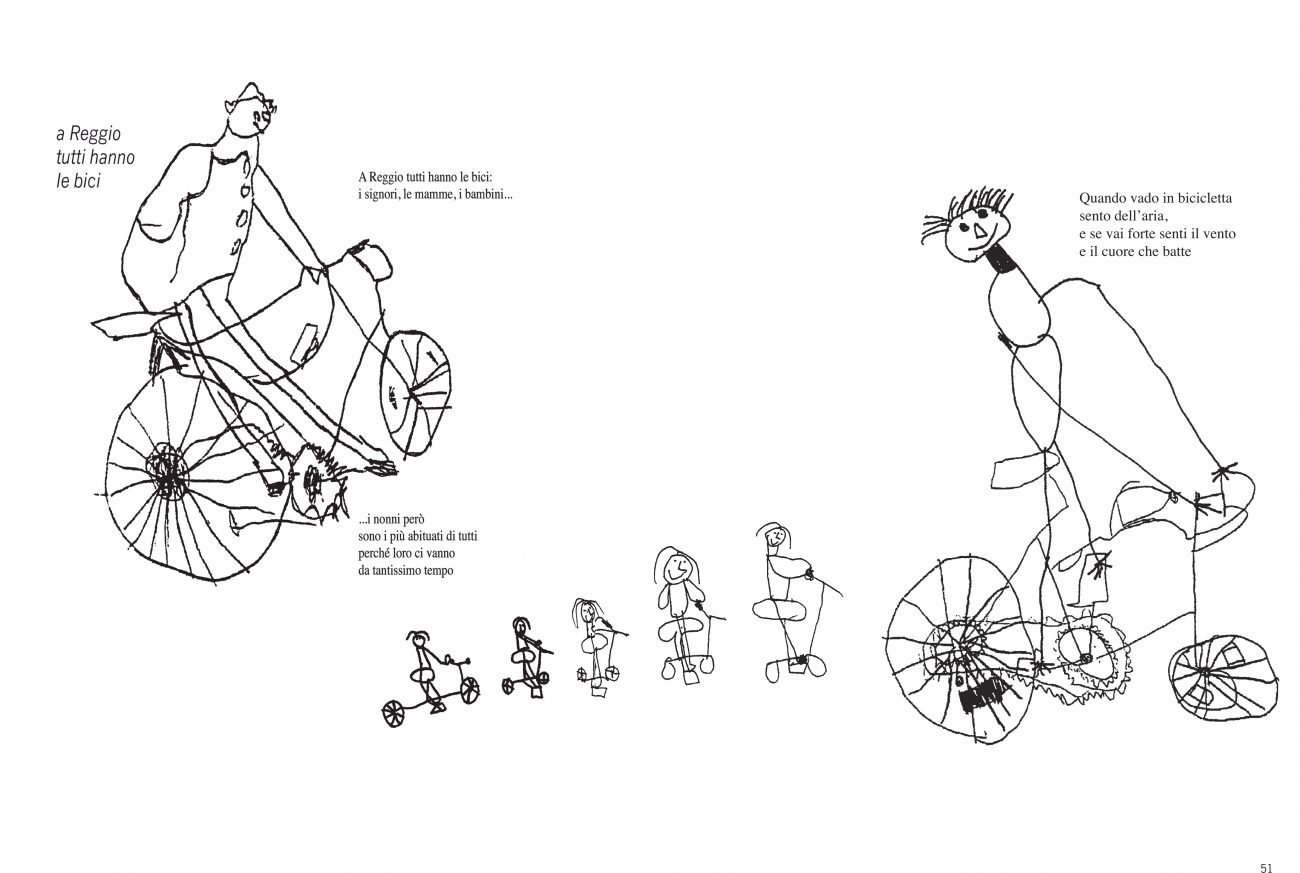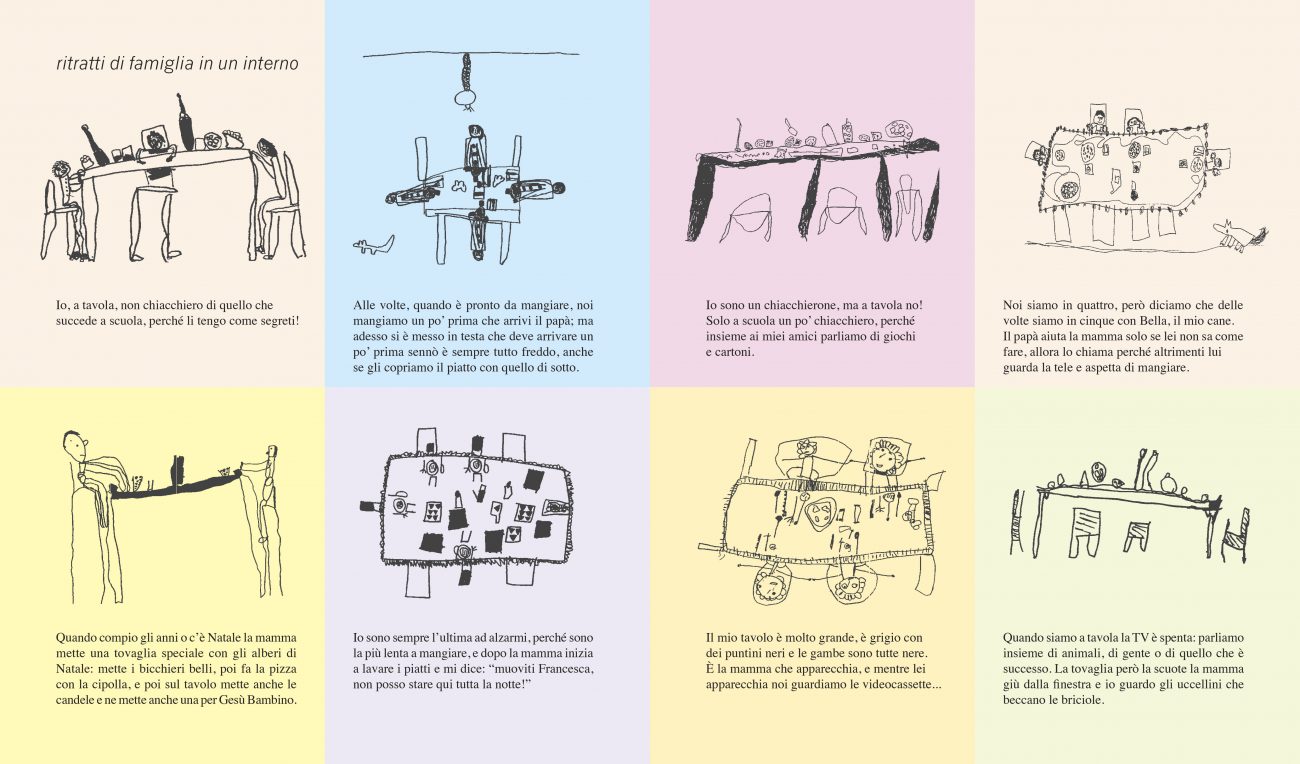Compasso d’oro, menzione d’onore alla medaglia d’oro dell’architettura italiana, Premio Inarch, tra i “cento Studi meglio al mondo” secondo Domus International 2019: sono innumerevoli i riconoscimenti che Guido Canali ha ottenuto nella sua lunga carriera di architetto. Eppure, con i suoi modi pacati e la sua grande serenità conquista con grazia, eleganza e pacatezza gli interlocutori, con cui ha una naturale capacità di apertura, dialogo, relazione. Le stesso doti che dimostra in tutti i suoi lavori, intrisi di accuratezza e di leggerezza, di rigore e di ossessione viscerale per l’efficacia condivisa.
Un dialogo costante con la natura e una grande capacità analitica gli hanno permesso negli anni di diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore, che guida con lieve maestria.
Non solo in Emilia, ma un po’ in tutt’Italia ed anche in Europa, ha svolto la sua carriera. Sul territorio emiliano, però, hanno avuto origine due progetti memorabili dedicati al Parmigiano Reggiano. Ce li siamo fatti raccontare.
A che cosa serve l’architettura?
L’architettura ben fatta è un investimento: se spendi male i soldi, sono sciupati. Vorrei che tutti capissero che l’architettura è un pregio irrinunciabile. Perché puoi comprare un quadro brutto e quando ti stufi lo metti in solaio, ma se costruisci una casa brutta o sbagliata non la puoi distruggere, perché ti costerebbe troppo, e hai fatto un danno.
Bisogna investire in qualità architettonica.
Ma non c’entra anche il gusto?
Il gusto c’entra: tra gli architetti ci sono quelli bravini e i negati, bisogna anche saper scegliere. Solo quello bravo ti aiuta veramente. Il gusto è educazione, impegno, un atteggiamento etico. Il gusto è non accontentarsi come principio. Essere esigenti con se stessi è davvero fondamentale e quando hai finito un progetto e pensi che potresti fare di più, ti viene voglia di buttare via tutto e rifarlo. L’energia per ricominciare ogni volta la si trova nella passione per quello che facciamo: quando sei convinto che quello che fai può essere utile agli altri, magari anche per le loro vite future, allora non ti accontenti.
Quanto di sé deve a questo territorio?
A parte il periodo di quando ero bambino, a cui devo la mia affezione verso la natura, abitare le nostre città emiliane è sicuramente stato determinante ed un reale privilegio. Puoi vivere nella città murata medievale, estremamente affascinante, che nei microambienti, in taluni casi in modo inaspettato ed affascinante, si apre in giardini segreti. Ma al di fuori della città murata c’è subito la campagna, e questo è un rapporto importantissimo che avresti con difficoltà se vivessi nelle grandi città.
Vivere in Emilia è un privilegio: abbiamo città d’arte bellissime, qualunque paese offre spazi e situazioni fantastiche.
Modena, Parma, Ferrara sono luoghi rilassanti, di grande equilibrio. Si vive bene. Vivendo qui uno ha già un po’ imparato come deve progettare.
E sul fronte del gusto?
Beh… sono un grande goloso di Parmigiano Reggiano: devo stare molto attento perché per me è una droga. Per fortuna non ho mai provato le droghe vere ma ne conosco altre, gastronomiche: il Parmigiano Reggiano e i funghi trifolati sono tra queste.

Come è nata la sua collaborazione con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano?
Il progetto del Consorzio è nato dalla mia amicizia con il presidente, che all’epoca era l’avvocato Mora, un parmigiano, un intellettuale che come hobby collezionava disegni del Parmigianino. Ci conoscevamo e dopo aver visto un po’ di cose che avevamo fatto ci ha incaricato di questo progetto, andato avanti per alcuni anni. Negli anni successivi abbiamo fatto cose abbastanza importanti in campo industriale, per esempio per Prada vicino ad Arezzo HQ abbiamo realizzato la sede principale del settore produttivo dell’azienda.
E tutte derivano dallo spunto di allora, la nostra linea guida filosofico-concettuale è di essere molto attenti alle condizioni di chi lavorerà nel luogo. Questo risultato non è così facile da ottenere e occorre anche l’intelligenza dei committenti. Ma per noi è fondamentale preoccuparci di creare delle condizioni ambientali, psicologiche, fisiche e utilizzare dei materiali che aiutino la serenità. Quando un operaio sta una giornata chino sui vari pezzi che gli passano davanti sulla catena di trasmissione poter alzare gli occhi e vedere il verde che entra nella fabbrica, avere moltissima luce e spazio è un aiuto alla fatica.
È l’esatto opposto di lavorare in un ambiente chiuso, cupo, senza vista sull’esterno: come quegli scatoloni industriali, quelle situazioni introverse, ancor oggi di moda dovuta a criteri di super economicità nella realizzazione degli involucri, con massimizzazione della funzionalità per ottenere solo il massimo profitto.
A Reggio c’erano già in luce queste attenzioni e abbiamo cercato anche di trasmettere, pur nella severità e semplicità geometrica del blocco, un racconto fantastico, un giardino che entra lungo una passerella con pendenza minima, utile anche ai disabili, perché l’accesso al complesso diventi passeggiata gioiosa, e nel progetto affiorino anche elementi quasi ludici.
La sede del Consorzio ha funzioni multiple: una zona che assomiglia a un caseificio, la sala prova del Parmigiano Reggiano, l’auditorium e poi gli uffici e gli ambienti per gli incontri. Il montaggio in sequenza di parti con funzioni diverse è tutto inserito in un volume che fuori è omogeneo, salvo la variazione delle finestre, per evocare la sobrietà dell’architettura casearia del passato. È vero che nella tradizione più antica si annoverano anche dei piccoli caseifici pensati come gazebi ottagonali col doppio fondo sul fuoco nel baricentro, ma spesso i caseifici nella composizione del nucleo rurale erano elementi molto sobri, asciutti e senza orpelli, e a quelli ci siamo ispirati.
Ho un rimpianto per la funzione della passerella, che nell’idea iniziale avrebbe dovuto valicare la via Emilia collegando il complesso a un parco, quasi un invito a full immersion nella natura. Ma anche questa idea, pensata per quel luogo, e rimasta purtroppo nella penna, l’abbiamo sviluppata dopo. Doveva essere un luogo aperto alla città: la passerella è un telaio che al piano terra avrebbe dovuto offrire spazi per una comunicazione visiva, una specie di mostra sul territorio di produzione del prestigioso formaggio. Queste erano le buone intenzioni, poi come in ogni progetto alcuni elementi devono essere sacrificati, però noi continuiamo a sognare.
Per me l’architettura deve partire dall’idea di fare qualcosa che gratifica la gente che ci vive e che quindi non solo ha un pensiero di riconoscenza verso chi ha creato quel luogo, ma l’entusiasmo a ritornarci: è questo il compenso più grande del nostro mestiere. Se rimane questa soddisfazione di aver fatto qualcosa che interessa, che suscita qualche emozione, che intriga chi poi deve usare l’edificio.
In tempi più recenti ha immaginato un nuovo caseificio.
Il caseificio di Montecoppe, certo: in quell’area c’era già un edificio degli anni ’50, obsoleto, in attesa di un intervento importante. E c’è ancora un piccolo caseificio della metà dell’800, una delle primissime realizzazioni neogotica in Emilia, quando il neoclassicismo va scemando come novità modaiola.
Questo era una delle prime realizzazioni a Parma: mattoni, finestre con ogiva appuntita, decorazioni in mattoni che formano cornici echeggianti quelle quattrocentesche. L’abbiamo restaurato ed è diventato lo spaccio dove oggi si vendono i prodotti del nuovo caseificio.
Questo l’ho progettato per un’importante e colta famiglia di industriali per cui avevo già fornito i disegni della Smeg a Guastalla.
D’accordo con i committenti, volevo fare un edificio non troppo alto, anche se il blocco magazzino di stagionatura, dovendosi all’interno modulare sull’automazione del trasporto delle forme, prevedeva un’altezza significativa, fino a 8 metri. Per annullare quest’altezza eccessiva in rapporto all’edificazione tradizionale del contesto agricolo, davanti al caseificio abbiamo rialzato un terrapieno, una specie di pianoro verde.
Visto in pianta è una elle: un braccio è dove si produce, l’altro è il magazzino. E per ridurre al minimo l’impatto tutto l’edificio è stato completamente coperto di verde, e si ambienta molto bene con i dintorni.
Anche questo piccolo complesso è un luogo d’incontro dove è piacevole andare: abbiamo posto le premesse perché si potesse realizzare anche un punto di ristoro che fosse occasione conviviale per la gente. È quasi una mia fissa: che l’architettura si apra e diventi un luogo frequentato e allegro, che costituisca il collante di una socialità partecipe.

E oggi, in un momento così chiuso, come si concretizza un’architettura di condivisione?
Adesso si progetta per quando si apriranno ancora i cancelli: per essere di nuovo pronti a realizzare, specie l’edilizia sociale e pubblica, che deve essere fatta bene, con amore e con cura.
In questo senso abbiamo una grandissima responsabilità: quanti quattrini sono stati buttati nelle periferie squallide con condomini brutti, pieni di famiglie? Questo è proprio un danno, soprattutto per i bambini, perché l’influenza dell’ambiente in età giovanile è fondamentale. Una persona viene plasmata da come vive, dall’ambiente in cui cresce, dalle sollecitazioni che percepisce.
Penso che il mio instancabile amore per la natura ed i reiterati tentativi di porla al centro, fisico e simbolico, di quel che costruiamo dipenda dal fatto che negli anni della guerra, da piccolo, ero in campagna con la famiglia sfollata, e lì abbiamo vissuto qualche anno. Ricordo ancora in technicolor le scorribande nei campi, e lungo le golene dei torrenti, le ghiaie che d’estate biancheggiano tra i pioppeti: un’esperienza che mi ha segnato.
Ritratti © Stefano Marzoli / Scaglie / LUZ